Un pittore ermetico del '500: Marco Bigio e le "Tre Parche"
Marco Bigio fu pittore senese del XVI sec., tra il 1523 e il 1550 allievo di Giovanni Bazzi detto il Sodoma, secondo il Vasari per le sue abitudini sessuali; la sua vita è poco conosciuta, un brevissimo accenno in un testo di metà ‘800, nel quale non è riportata la fonte della notizia, lo descrive come “nominato tra gli artisti più celebri suoi contemporanei e concittadini”[1].
Tra i dipinti del Bigio (sicuramente suoi o a lui attribuiti) due sono particolarmente interessanti per una possibile lettura su più livelli: Le tre Parche (ca. 1530-1540, Palazzo Barberini, Roma) FIG. 1 e Venere, o Le tre età della donna (ca. 1545, Pinacoteca Nazionale di Siena) FIG. 2.

Fig. 1: Marco Bigio, Le tre Parche, ca. 1530-1540, Pinacoteca Palazzo Barberini, Roma
(da Wikimedia Commons, pubblico dominio).

Fig. 2: Marco Bigio: Venere con figure allegoriche, o Le tre età della donna, ca. 1545, Pinacoteca Nazionale di Siena (riproduzione su concessione dei Musei Nazionali di Siena).
Ambedue le tele sono ricche di elementi allegorici confacentisi al periodo in cui vennero dipinte, nel quale si andava diffondendo la riscoperta del patrimonio letterario, religioso e sapienziale degli Antichi: si pensi alla scoperta del c. d. Corpus Hermeticum e alla traduzione e commento di Marsilio Ficino e della sua cerchia, o all’accostamento della Qabalah al pensiero cristiano operato dal cardinale Egidio da Viterbo o infine al recupero della storia e dei rituali di Roma con l’Accademia Romana di Pomponio Leto. Ma questi dipinti del Bigio sono soltanto allegorici o hanno un significato più profondo, che si lega al simbolismo dell’Ermetismo e dell’Alchimia? Queste discipline tra la fine del XV e il XVI secolo erano state rese manifeste in Italia grazie all’Accademia Neoplatonica di Firenze e a personaggi quali il pontefice Paolo III (Alessandro Farnese il Vecchio) e il nipote Alessandro il Giovane con la loro cerchia di cardinali, nobili e artisti, dando così luogo a quello che si potrebbe chiamare il “Rinascimento ermetico”, parallelo al “Rinascimento artistico” che sempre a Firenze aveva avuto origine.
L’origine del soggetto del quadro (e forse anche del suo committente) si può ritrovare nell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto[2] ed esattamente dai canti XXXIV strofe 89-92 e canto XXXV strofe 11-20: l’opera dell’Ariosto insieme a quelle dei due Tasso, Bernardo e il figlio Torquato, a dimostrare i legami tra Rinascimento artistico e Rinascimento ermetico, sarebbero state anche l’ispirazione per alcuni gruppi statuari del Sacro Bosco di Bomarzo secondo l’ipotesi del Calvesi[3], probabilmente per la conoscenza che Vicino Orsini, signore di Bomarzo ed artefice del Sacro Bosco, aveva delle opere dei tre poeti (era stato in particolare mecenate di Bernardo, padre di Torquato Tasso e autore dell’Amadigi).
Ritengo che l’ipotesi di un senso ermetico-alchemico dell’opera di Marco Bigio sia proponibile e cercherò di illustrarla con un esame del primo dipinto, Le tre Parche, ricco di complessi significati che non sarà facile portare integralmente alla luce.
Le figure rappresentate nel quadro possono posso essere divise in tre gruppi, ognuno avente al centro una delle tre Parche, raffigurate insolitamente con le forme aggraziate di belle donne più o meno poco vestite. Noto per inciso che le Parche ritratte dal Bigio sono esemplate, secondo la tarda interpretazione romana, non sulle divinità originali ma sull’identificazione con le Moire greche, differenti da quelle romane per significato e gesti (le Moire filano i destini, le Parche li “cantano” – sono anche chiamate le Tria Fata – leggendoli nelle stelle e scrivendoli su di un volumen)[4].
A sinistra vi è Lachesi (che di norma nella triade delle Parche è invece posta al centro), la quale avvolge un filo di rosso sulla conocchia; dietro di lei uno scheletro con la falce, a sinistra due cigni candidi; sulle sponde del fiume che scorre alle sue spalle si intravede un soggetto con un bastone in mano, forse la divinità del fiume, e due piccoli uccelli posati sull’infiorescenza di un giunco palustre; sullo sfondo un albero frondoso e in alto a sinistra, al di là del fiume, un palazzo a cui si accede con una scalinata, una colonna isolata e dietro ad essi le rovine di un monumento, che potrebbe essere il ricordo del Colosseo.
Al centro Atropo, la più anziana delle tre Parche secondo il mito (la quale nel quadro è infatti la figura più coperta dal vestito) ha in mano le forbici per tagliare il filo, sullo sfondo un albero secco e altre figure enigmatiche: dietro di lei a sinistra una donna negra con ricchi monili insieme a un coniglio o una lepre e un levriero, a sinistra un uomo anziano con una clessidra nella mano destra, il quale regge in un lembo della veste alcuni dischi o “piastre” di vario colore (ferro o piombo, argento e oro?); ai piedi di Atropo due putti giocano con “piastre” simili a quelle tenute in grembo dall’anziano.
A destra Cloto, la più giovane, ha in mano il fuso con cui intreccia un filo bianco, in basso a sinistra un Eros alato punta il suo arco contro l’uomo anziano, dietro a destra una figura di donna vestita con un peplo che con la mano destra regge qualcosa di cui si vede solo la parte superiore dietro la schiena di Cloto.
I sensi allegorici del quadro sono chiari: Atropo è colei che decide il momento stabilito per la morte di ciascun essere umano tagliando il filo della sua vita, l’albero secco dietro di lei ne costituisce l’emblema, sottolineato dalla altre figure, la donna negra (il nero come colore della morte) accompagnata da due animali, la lepre[5] FIG. 3 e il levriero FIG. 4, simboli della velocità e, in questo caso, della caducità dell’esistenza[6], e il Tempo, l’anziano con la clessidra e le “piastre” di diversi materiali raccolti nel lembo della veste, nelle quali si possono vedere le “piastre” di cui parla l’Ariosto: “erano in brevi piastre i nomi impressi, / altri di ferro, altri d’argento o d’oro” (canto XXXIV strofa 91).
Nel quadro infatti alcune di queste “piastre” d’oro portano incisi nomi, tra cui quelli di Alfonso e di Lucrezia, forse Alfonso I d’Este e sua moglie, la ben conosciuta Lucrezia Borgia, e questo fa supporre che siano stati gli Este i committenti del quadro; Ludovico Ariosto fu al servizio della famiglia degli Este, prima di Ippolito, a cui dedicò l’Orlando furioso, e in seguito di Alfonso I, e questo potrebbe spiegare sia la scelta di ispirarsi alla sua opera come soggetto del dipinto del Bigio, sia i nomi che si leggono sulle “piastre” nel quadro.
I nomi incisi sulle “piastre” fanno ipotizzare che forse il cardinale Ippolito fu il committente, il quale volle così ricordare i nomi del fratello Alfonso e della cognata Lucrezia: poiché il primo era deceduto nel 1534 e la seconda nel 1519, l’esecuzione del dipinto negli anni tra il 1530 e il 1540 confermerebbe la volontà di Ippolito di ricordarli i suoi fratelli come personaggi di fama immortale, il cui nome è salvato dall’oblio.
Se fosse Ippolito il committente, ciò ci riporterebbe al più ampio contesto ermetico dei rapporti che hanno unito i tre cardinali, Alessandro Farnese il Giovane, Ippolito d’Este e Gianfrancesco Gàmbara, i quali portarono al massimo livello il Rinascimento ermetico nella regione tra la Tuscia laziale e il territorio di Roma con la costruzione delle loro ville ermetiche.

Fig. 3: Aurora consurgens (attribuita a Tommaso d’Aquino): l’Androgine con il pipistrello nella mano destra e la lepre nella sinistra (Zurigo, Zentralbibliotek, ms Rh 172, guardia anteriore, riproduzione da Jacques van Lennep, Alchimia, Edizioni Mediterranee, Roma 2020, con l’autorizzazione della Casa editrice).

Fig. 4: San Cristoforo con il piccolo Gesù sulla spalla sinistra accompagna un vescovo: Cristoforo è cinocefalo, immagine frequente nelle ione del XVIII-XIX sec. nell’Europa orientale (icona XVIII sec,. Museo delle Icone, Recklinghausen).
La “morte” simboleggiata dallo scheletro è figurazione del superamento del piano terreno per ascendere ai livelli superiori dell’essere: il segno è la presenza alla destra del dipinto di Cloto, la quale attorce col fuso il filo bianco simboleggiante la nascita che è ri-nascita, protetta dal piccolo Eros alato che tiene a bada con il suo arco il Tempo-Cronos, e la nudità di Cloto potrebbe indicare la nudità rituale del nuovo uomo che ora viene in vita. La figura femminile dietro Cloto potrebbe essere identificata con Nemesi, la Dèa della giustizia (in questo caso della giusta distribuzione dei destini), come ad esempio si vede su di un sarcofago del II sec. d.C. trovato a Villa Pamphilij[7] FIG. 5, il che vorrebbe dire che, durante il suo soggiorno romano durante il quale lavorò con il Sodoma, Marco Bigio ebbe modo di interessarsi alle antichità romane che stavano ritornando alla luce.

Fig. 5a: Nella parte sinistra della fronte del sarcofago si vede la puerpera seduta a cui la nutrice presenta il neonato e dietro di lei le tre Parche e, dietro la terza, una figura femminile interpretata come Nemesi, Dèa della Giustizia (Margherita Bonanno, in AA. VV., Antichità di Villa Doria Pamphilij, tav. 160).
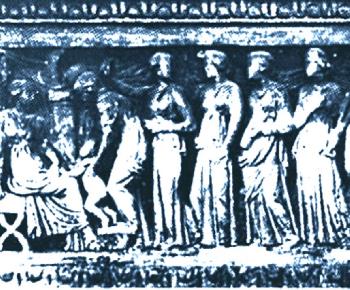
Fig. 5b: Particolare dell’immagine precedente: la prima misura con un compasso un globo posto su di una colonna per determinare l’influsso delle stelle sul futuro del neonato (come si vede in altri sarcofagi più chiaramente), mentre la terza porta in mano un rotolo su cui scrivere il responso astrologico.
Lachesi, forse la figura più complessa del dipinto, è rappresentata nell’atto di avvolgere sulla conocchia il filo di colore rosso, il colore della vita, con cui contrasta lo scheletro che si trova dietro di lei ma sotto un albero frondoso e non più secco come quello che accompagna Atropo; lo scheletro forse indica l’avvenuto superamento della condizione fisica e mortale. Alla destra di Lachesi scorrono le acque di un fiume, segno della purificazione necessaria per “attraversare le acque” e giungere alla scalinata che conduce al palazzo che si vede sulla collina, sul quale s’innalza una colonna (l’axis mundi?). Le rovine dietro il palazzo potrebbero indicare che questo rituale di ri-nascita simboleggiato nell’azione delle Parche ha la sua origine nella sapienza degli Antichi.
Il fiume all’estrema sinistra del quadro, sulle cui rive è seduto il nume tutelare con un bastone in mano, nei versi dell’Ariosto è il Lete: il Tempo getta in esso le “piastre” con i nomi degli umani perché siano dimenticati, ma due cigni salvano alcune di esse e una divinità li consacra per l’eternità inchiodandoli su di una colonna: “in quel fiume che Lete si noma, / scarcava, anzi perdea la ricca soma”, mentre solo alcune “piastre” si salvano dall’oblio grazie a due cigni, “son duo cigni soli / … / che vengon lieti riportando in bocca / sicuramente il nome che lor tocca. / … / alcun ne salvan gli augelli benigni: / tutto l’avanzo oblivïon consume”[8]. Soltanto questi nomi sono conservati a imperituro ricordo da una “ninfa” che affigge le piastre su di una colonna: “una bella ninfa giú del colle / viene alla ripa del leteo lavacro, / e di bocca dei cigni i nomi tolle; / e quelli affige intorno al simulacro / ch’in mezzo il tempio una colonna estolle”.
Alternativa all’identificazione del fiume nel dipinto con il Lete dell’Ariosto potrebbe essere l’ipotesi di un suo riconoscimento come il Tevere, il che dimostrerebbe di nuovo la conoscenza e l’interesse di Marco Bigio per le antichità romane (d’altronde anche il monumento sul fondo è reminiscenza del Colosseo): nel 1512 era stata riportata alla luce la statua colossale in marmo di Tiberinus trovata tra S. Maria sopra Minerva e S. Stefano del Cacco nella zona dell’Iseo di Campo Marzio FIG. 6: la statua ha in mano un remo che potrebbe essere stato interpretato dal Bigio come un bastone, e così infatti tre secoli più tardi lo disegnò il Pinelli nell’incisione raffigurante Tiberino ed Enea FIG. 7.

Fig. 6: Statua di Tiberinus (marmo; età adrianea): la statua, rinvenuta nel 1512 nell’area dell’Iseo di Campo Marzio, ora al Louvre, potrebbe aver ispirato la figura della divinità fluviale alla destra di Lachesi nel dipinto del Bigio (Wikimedia Commons, pubblico dominio.
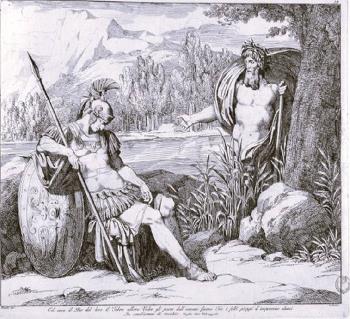
Fig. 7: Nell’VIII libro dell’Eneide Virgilio descrive la predizione ricevuta da Enea durante il sonno da Tiberinus della scrofa gravida simboleggiante i trenta anni dopo i quali il figlio Ascanio fonderà Albalonga. Nell’immagine del Pinelli il Dio porta un bastone nella mano sinistra (Bartolomeo Pinelli, acquaforte, da Istorie romane. Presso Vincenzo Poggioli stampatore. Roma 1821).
Il quadro del Bigio può essere esaminato non come costituito da gruppi isolati di personaggi ma come un insieme da leggere secondo una precisa direzione, ma quale sarebbe la direzione secondo cui andrebbe letto?
Questo è difficile da stabilire per l’anomalia della distribuzione delle tre Parche, le quali non seguono l’ordine descritto nel mito, dalla più giovane, Cloto, alla più anziana, Atropo: apparentemente si dovrebbe scegliere se leggere il dipinto da sinistra verso destra, cioè a partire da Lachesi, o al contrario da destra verso sinistra, cominciando con la figura di Cloto; invece secondo me il senso di lettura è proprio quello che ha dipinto il Bigio, ponendo al centro la figura di Atropo (morte) per passare a destra in direzione di Cloto (nascita) e da questi a Lachesi (compimento), seguendo quindi un movimento circolare antiorario.
Seguendo quest’ordine il dipinto diviene l’esposizione di un trattato ermetico per immagini: l’artifizio pittorico di Marco Bigio sembra porre al centro del dipinto la morte come momento dominante, ma la disposizione circolare delle figure lascia intendere che non è “morte” bensì “rinascita” il significato dell’opera, perché si muore, si ri-nasce e si giunge al compimento spirituale attraverso la morte al mondo materiale.
Se si vede l’opera in quest’ottica, si nota come ciascuna delle Parche presenta un duplice simbolismo che potrebbe essere ricondotto alle tre fasi alchemiche: Cloto fila il filo bianco della conocchia simboleggiante l’albedo ed ha accanto a sé Eros, l’Amore-Fuoco della rubedo; Atropo recide il filo, simbolo della morte e della nigredo (simbolismo accentuato dalla presenza del tempo, della schiava nera, della lepre, simbolo della caducità della vita, del cane, animale ctonico, e dell’albero secco), mentre due putti ai suoi piedi giocano con “piastre” di tre metalli, rappresentando il superamento del coinvolgimento nel materiale e il ludus puerorum, quindi la rubedo compimento dell’Opera; Lachesi è riunisce i simboli della nigredo (lo scheletro), dell’albedo (i cigni bianchi) e della rubedo (il filo rosso che avvolge sul fuso), dando accesso a un piano di esistenza superiore, la scalinata che conduce al palazzo e all’origine di questa sapienza, indicata dalle rovine monumentali dell’antica Roma.
[1] Filippo De Boni, Biografie degli artisti, Tipografia Il Gondoliere, Venezia 1840, p. 105.
[2] Scheda della Galleria Nazionale Barberini, https://barberinicorsini.org/artwork/?id=WE4788. Ricordo che la prima edizione dell’Orlando furioso fu pubblicata nel 1516 e l’ultima nel 1532
[3] Maurizio Calvesi, Gli incantesimi di Bomarzo. Il Sacro Bosco tra arte e letteratura, Bompiani, Milano 2000. Sul Sacro Bosco, le sue statue e i possibili rapporti con l’opera del Tasso ho scritto in Vicino Orsini e il Sacro Bosco di Bomarzo, pubblicato il 27/06/23 sul sito www.simmetria institute.com.
[4] Di questo ho trattato nel saggio Parca Marzia, Dèa della profezia pubblicato il 20/09/25 sul sito www.simmetria institute.com.
[5] La lepre era un’immagine nota agli studiosi di Alchimia del tempo perché presente nell’incisione dell’Androgine dell’Aurora consurgens fin dal XIII sec. (Zurigo, Zentralbibliotek, ms Rh 172, guardia anteriore, riproduzione da Jacques van Lennep, Alchimia, Edizioni Mediterranee, Roma 2020, con l’autorizzazione della Casa editrice).
[6] Ambedue gli animali sono, come devono essere i veri simboli, ambivalenti: la lepre è simbolo di velocità ma anche di sessualità sfrenata (in Alchimia è immagine del servus fugitivus, il Mercurio non fissato), così come il cane è simbolo di fedeltà, è la guida nell’Oltretomba (come Anubis in Egitto; nel cristianesimo dell’Europa orientale San Cristoforo a volte è raffigurato con testa di cane, come si vede icone del XVIII-XIX sec. conservate nel Museo delle Icone di Recklinghausen) e contemporaneamente considerato animale sporco e impuro (a Roma era proibito che i cani entrassero nel temenos dell’Ara Maxima). Secondo lo Chevalier e il Gheerbrant il cane sarebbe in Alchimia simbolo dell’Oro (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Rizzoli, Milano 2002, vol. I p. 191).
[7] Margherita Bonanno, in AA. VV., Antichità di Villa Doria Pamphilij, Editore De Luca, Roma 1977, tav. 160, citato in Stefano De Angeli, Problemi di iconografia romana: dalle Moire alle Parche, in “Mélanges de l'École française de Rome, Antiquité”, 103, 1, 1991, pp. 105-128, doi: ttps://doi.org/10.3406/mefr.1991.1704, https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1991_num_103_1_1704 (consultato 31/07/2025), p. 115 nota 51.
[8] Canto XXXV, strofe 11 e 14-15.
![]()
Nota del webmaster: articolo pubblicato in questo sito il 30/10/2025 dietro autorizzazione dell'autore. Non è permesso il copia/incolla altrove, senza il consenso dell'autore dr. Paolo Galiano.
